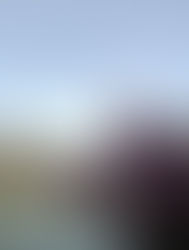Il fratello brutto del cavedano
- La Redazione
- 23 apr 2024
- Tempo di lettura: 9 min
Aggiornamento: 14 giu
Testo e foto di Massimo Zelli

E’ un pesce particolare, l’aspio. Merita certamente l’attenzione dei pescatori a passata.
Venerdì 28 Novembre 2008
La giornata volgeva al termine, ma i barbi, in quell’innevato novembre, non volevano saperne di allentare il ritmo. Dopo la prima di pesca ora avevamo deciso per un salomonico “su le nasse” poiché il rischio di ammassare più di 100 kg di pescato era concreto e questo, già allora, per me non era etico a sufficienza, considerando la già poca etica che c’è nel ficcare un ferro in bocca ad un pesce. Procedemmo a ritmo serrato fino a circa le 4, ci si vedeva poco, ma gli sguardi mio, di Piero e di Maurizio che si incrociavano, prefiguravano la chiusura delle canne solo quando non ci sarebbe stata più luce per pescare. Eravamo talmente presi dalla faccenda che mi scappò una perla di saggezza di quelle da annali della stronzata:<< Non vi preoccupate, tanto con la neve per terra le notti non sono mai troppo buie… il bianco riflette>>. A Piero sfuggì un mezzo sorriso con l’ennesimo barbo in canna. Maurizio realizzò che oramai mancavano pochi minuti al tramonto. Cominciò a chiudere la canna borbottando qualcosa sul fatto che era da incoscienti stare fino a quelle ore a qualche chilometro dalla civiltà, nella neve, dispersi in una landa desolata del Po. << Se ci piantiamo con la macchina non sappiamo nemmeno dove cercare un trattore!>> disse sconfortato.
L’anatema ebbe un effetto pressoché immediato. Dichiarai l’ultima passata per la quinta volta, quella definitiva. Stavo per recuperare e quindi chiusi l’archetto. Il finale doveva essersi già sollevato dal fondo dando luogo ad una delle poche passate a vuoto di quel giorno. Proprio mentre mettevo la mano sul mulinello, vidi una mangiata che pareva una schioppettata. Andai a vuoto. Esclamai:<< Forse ho sbagliato un cavedano!>>.
Piero in risposta disse:<< Cominci ad avere quelle allucinazioni che hanno i ricercatori in Antartide. Sono causate dal buio e dalla neve!>>.

Maurizio aveva già chiuso, cedetti la mia canna a lui e cominciai a rinsaccare la roba alla bell’e meglio visto che non si vedeva più nulla. Alle mie spalle sentì il suono inequivocabile di una ferrata.
<< E’ un bel pesce>> disse. << Non credo sia un barbo, va troppo veloce>>.
Avevo chiuso quasi tutto e mentre avevo ancora il capo chinato nella borsa gli dissi:<< Dai tiralo fuori, così vediamo cos’è e te lo fotografo>>.
Non era un cavedano ma gli somigliava parecchio. Quel pesce non lo fotografammo. Complice il freddo la vecchia D40 non voleva saperne di fare foto. Segnava batteria scarica. Le foto comunque non servirono, almeno a me, perché quel pesce mi rimase impresso per un pezzo. Era parecchio grosso, un pesce sui due chili e mezzo abbondanti, affusolato, era di certo un ottimo nuotatore. La coda biloba e robusta era un chiaro indizio di capacità acquatiche spiccate. Sembrava più un pesce pelagico che di fiume. Aveva un muso piuttosto acuminato, non sembrava proprio un ciprinide. Le sembianze erano quelle di un cavedano, soltanto molto allungato, più minaccioso decisamente. -Il fratello brutto del cavedano – pensai tra me.
Era la prima volta che vedevo un Aspio dal vivo. Ero abituato alla fauna dei fiumi veneti di quegli anni quindi, tolto breme, gardon e carassi, non avevo grosse chance di incontrare pesci alloctoni. Per me era un pesce nuovo. Ne avevo sentito parlare soltanto sulle riviste e soltanto a proposito di spinning. Non avevo idea di che animale fosse, né di quanto potesse essere casuale o meno la sua cattura a bolognese, né che si trattasse di un pesce estremamente sportivo da catturare.
Per essere onesto guardavo con sospetto anche i barbi europei, non avevo grossa simpatia per gli alloctoni in genere. A quel tempo non mi era del tutto chiaro quanta irreversibilità ci fosse in alcuni errori, né quanto, nonostante gli errori, potessimo, con adeguate distinzioni e regole precise, considerare risorse i pesci autoctoni.
La conservazione dello stato in cui le risorse della pesca versano in questo momento va mantenuto e preservato.

Per essere precisi: è da inchiodare su una croce chi parteggia per quella marmaglia, anche se in maniera silente e dignitosa, che sta ripulendo i nostri fiumi e i nostri canali dagli alloctoni. I “tifosi” di questi bracconieri vivono nella speranza che miracolosamente riappaiano savette e cavedani. Nel frattempo si estingueranno anche i pescatori e allora avremo un mondo migliore.
Allo stesso modo mi piacerebbe appendere per i cosiddetti, lasciandoli a dondolare un bel po’, coloro i quali in ragione del proprio tornaconto e divertimento hanno seminato alloctoni in posti dove obiettivamente, non essendo questi ultimi dotati del dono della deambulazione in terra, né del volo, avrebbero potuto arrivare. Ma questa, come al solito, è un’altra storia.
Lucifughi ed onnivori con eccezioni
La deduzione che a freddo feci su quei pesci e su quella giornata fu in realtà non del tutto semplice. Avevo notato mangiate estremamente rapide, tipo cavedano, al mattino presto e al calar del sole. Il fatto che non le avessi prese lo avevo imputato giustamente alla montatura: una grezza geometria dotata di pallettone con un finale lungo e piombato. Esattamente quello che non serve per un pesce rapido a mangiare.
L’altro aspetto che avevo erroneamente assegnato ad un'altra natura era la presenza di questi pesci in pastura: i fatti indicavano che fossero aspi.
Il passo logico era il seguente: quando i barbi arrivano la confusione generata scaccia gli aspi. Non era così. L’aspio è un pesce che in giornate luminose sta al riparo negli anfratti delle prismate e esce in caccia o in attività soltanto con condizioni di scarsa luminosità: albeggio e tramonto. E’ un animale lucifugo. Cresce inoltre fino a 9 Kg e può raggiungere un metro di lunghezza. E’ un pesce che all’aumentare dell’età e della taglia diviene prevalentemente ittiofago, perdendo in parte il carattere “onnivoro” che lo accomuna al cavedano.
Questa piccola premessa serve semplicemente a stabilire i campi ed i limiti di utilizzo della bolognese nella cattura di questo eccezionale predatore. In giornate particolarmente soleggiate e nelle ore centrali sarà difficile catturarlo. Sarà invece molto comune avere attività tutto il giorno nelle giornate invernali e primaverili di scarsa luminosità. Arriviamo al punto che interessa tutti: fino a che taglia si può arrivare in bolognese? Con un po’ di fortuna anche 6 o 7 Kg. Se il finale tiene e il pesce mangia, non è impossibile.

Volendo essere più obiettivi: è abbastanza raro che un pesce sopra 4-5 Kg si lasci ingolosire da una fumata di bigattini. E’ un po’ come per la pesca alla spigola: più si sale di taglia più serve un esca specifica. In aggiunta a questo: un onnivoro che è però prevalentemente un predatore non è insensibile al richiamo di proteine servite con uno sforzo minimo, nella fattispecie la fiondata di bigattini di cui sopra. Esso avrà però un’altissima possibilità di aver già sperimentato il gusto dell’acciaio al carbonio a filo di gengiva, quindi: a voi le conclusioni.
In Adda basso al giorno d’oggi
Partire da casa e pensare, oggi si va a caccia di aspi, era sinceramente una faccenda che dovevo ancora sperimentare fino al 12 marzo del 2016. In qualche anno di Po, Adda basso e affluenti m’era successo di prenderne. M’era persino successo di mettermi a pescarli per un paio d’ore, soltanto loro, quando pensavo che questi fossero più attivi usando lenze leggere. Non ero mai partito con l’idea di dare la caccia a loro tagliando fuori il barbo con cui divide buona parte degli habitat.
Occorre fare questo almeno una volta se si vuole davvero capire che tipo avversario possa essere l’aspio. Prenderlo per caso mentre si pesca a passata non ha la minima valenza nell’insegnare al pescatore qualcosa su questo pesce. Carlo, il complice di tante malefatte, questa volta era stato molto chiaro:<<Dimenticati la canna da barbi da una parte, devi pescarli come se andassi a cavedani nello stesso posto, incluso il fatto di usare terminali non tanto grossi>>. L’ultima parte me la rimuginavo mentre guidavo sullo stradone bianco che conduce al fiume:<< Non sarà facile lavorare uno di quegli arnesi con un finale del 12 o dell’11>>.

In Adda basso la popolazione di aspio è notevolissima. Il particolare ambiente, nei pressi della diga di Pizzighettone e per 5-6 km a valle, è fatto di bassi fondali alternati a buche e raschi. E’ un terreno di caccia e riproduzione ideale per questi pesci. Vanno a branchi non troppo numerosi quando sono di taglia elevata: 5-6 esemplari al massimo. Scelgono però zone molto specifiche dove stazionare: il fatto di trovare più branchi non è raro. Le lame con acqua bassa a valle dei fine buca sono da considerarsi delle pool molto buone. Questo tipo di pesce è un ciprinide atipico, non è un grufolatore per predilezione. Il fatto che scelga i bassofondi successivi alle buche è strettamente legato a come esso cerca il cibo: in velocità e a mezz’acqua. L’Adda a momenti alterni ha dato schiuse di effimere da far ingolosire qualunque trota o cavedano. L’aspio, con mia grande sorpresa, m’è stato spiegato non essere così insettivoro come invece avrei supposto. Di fatto non ho visto una bollata che fosse una.
La tecnica di pesca necessaria ad insidiare a bolognese questi pesci è di impostazione molto minimale, non servono quintali di pastura, trapani, secchi, etc. Basta la canna, la fionda e una sacca di bigatti al collo. Gli aspi possono posizionarsi su vari strati d’acqua, possono mangiare sul fondo o staccati. Rispetto al cavedano preferiscono, variabilmente rispetto agli ambienti e alle condizioni di questi, mangiare sollevati dal fondo. Durante tutto l’arco della giornata abbiamo pescato su circa 1,8 metri sia stando ben in terra che staccandoci anche di 30-40 cm. Non è un record ma è un indicazione molto chiara di come questo “simil-cavedano” agisce, considerando che in marzo l’acqua non è poi così calda da far sollevare il pesce naturalmente.
A fionda e veloci

Tralascio le varie prove effettuate per una sintetica e sommaria cronaca dell’approccio che ha reso meglio. Dimentichiamo i finali lunghi e le scalate “in stile peschiera”: due sono state le lenze che hanno retto il gioco. Una scalata medio lunga a bottoni di camicia ed una più leggera e più corta a geometria inversa. Entrambe le lenze erano dotate di un finale di circa 30 cm.
La lenza a bottoni di camicia era sul grammo e mezzo ed era distribuita su circa 70 cm. Completa di terminale arrivava al metro scarso. Era composta da 15 pallini di misura crescente verso l’alto equidistanti. Abbiamo pescato con questo schema fiondando bigattini circa 10 metri a monte di noi e cercando pesce sul fondo o staccati di 5 centimetri.
Uno schema a pallini equidistanti ha un vantaggio rispetto ad altri: consente una grande verticalità della lenza quindi una segnalazione piuttosto immediata. Non è molto morbido nelle fluttuazioni ma questo viene mitigato dal fatto che va utilizzato, in questo contesto, dimezzando il peso che una lenza normale utilizzerebbe.
In sostanza si tratta di passare molto veloci, alla velocità della corrente, seguendo il treno dei bigattini che vengono trascinati a valle a fil di fondale.
Pescando su un fondale irregolare, vortici e rigiri sono all’ordine del giorno. Una lettura della corrente attenta è fondamentale per capire dove posizionarsi e dove lanciare le nostre fiondate.
L’altro schema utilizzato è ancora più estremo: prevede un montatura più leggera di un terzo. Siamo sul grammo: la lenza non è più lunga di 50 cm e prevede una realizzazione con soli pallini del numero 8. Partiamo vicino l’asola a mezzo cm di distanza e aumentiamo di mezzo centimetro alla volta, salendo progressivamente fino a taratura.
Lo schema è ultra rigido ma anche ultra leggero. Il finale come nel caso precedente è sui 30 cm ma si può scendere anche a 20-25 nel caso di mangiate particolarmente rapide.
Questo metodo estremo è congeniale quando si pesca staccati di molto dal fondo. Il bigattino è impiccato ma la velocità estrema della lenza non dà modo al pesce di accorgersi dell’inganno: il tempo che questo ha per decidere è troppo breve. In tale frangente occorrerà stare più corti con la fiondata, dovremo fare in modo che la calata dei bigattini intercetti la nostra esca davanti a noi o poco a valle per essere repentini e precisi sulla ferrata.
Lunga o corta?

Ci sono due approcci tipo: canna lunga o canna corta. Per canna corta intendiamo una bolognese dai 4 ai 5 metri. Questo tipo di canna non ha assolutamente controllo quando si pesca a più di 10 metri dal pescatore. In questo range però nessuna canna lunga può competere come velocità di ferrata.
Per canna lunga intendiamo una 6-7 metri. E’ ideale per pescare sulla linea più esterna, tra i 12 e i 15 metri. In questo caso la lenza subisce un lieve controllo.
Nel caso di utilizzo di canne lunghe occorre attuare un piccolo stratagemma. E’ molto opportuno tenere tutto il filo fuori dall’acqua. Questo ci darà quel piccolo vantaggio sul pesce al momento della ferrata: in qualche caso questo farà sì che si verifichi una auto-ferrata.
Pro e contro? Le canne corte sono più agili da gestire, non affaticano e in taluni casi innalzano il numero di ferrate a segno. Le canne lunghe forniscono quel grado in più di controllo che occorre per guidare le lenze un po’ più distante e offrono grossi vantaggi in caso di pesci di taglia extra.